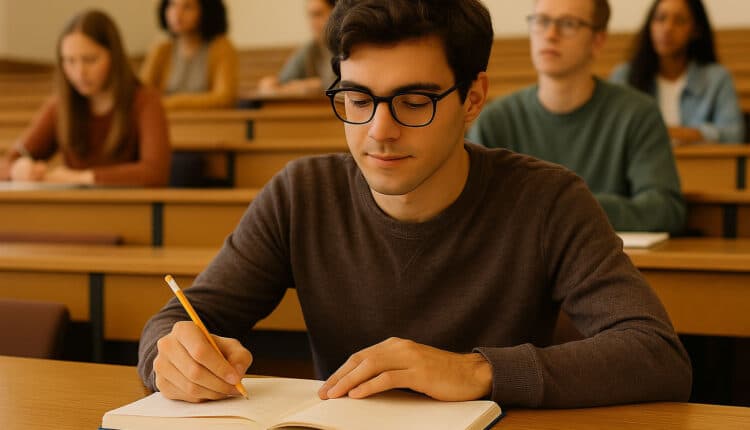Vivere meglio lo studio accademico con un disturbo certificato
Riconoscere i sintomi, accedere a una diagnosi clinica e richiedere accomodamenti: una guida pratica per affrontare l’università tutelando la salute mentale.
Vivere meglio lo studio accademico con un disturbo certificato.
Quasi un universitario su tre sperimenta sintomi di ansia clinica e più di uno su quattro convive con forme di depressione che compromettono studio, relazioni e benessere. Queste difficoltà incidono fino al 35% del percorso di studi, rallentando la preparazione degli esami e la capacità di mantenere la motivazione. Eppure, per molti studenti, arrivare a una diagnosi ufficiale resta un percorso complicato, pieno di esitazioni e ostacoli burocratici.
Riconoscere che non si tratta di semplice pigrizia o fragilità è il primo passo per chiedere aiuto senza vergogna. Dalla presa di coscienza dei sintomi persistenti alla certificazione clinica, esiste un iter strutturato che permette di ottenere accomodamenti ragionevoli e piani di supporto personalizzati. Sapere come funziona, a chi rivolgersi e quali strumenti sono disponibili può fare la differenza nel vivere con più serenità l’università e nel proteggere la propria salute mentale.
Ascoltare i segnali: non è solo pigrizia
Molti studenti tendono a sottovalutare i primi campanelli d’allarme, convinti che sia solo una fase passeggera o un problema di motivazione. In realtà, sintomi come difficoltà di concentrazione, apatia prolungata, attacchi di panico o una sensazione di disorganizzazione costante non vanno ignorati se si protraggono per più di due settimane consecutive. Questi segnali possono indicare l’inizio di un disturbo psicologico clinicamente significativo, che non ha nulla a che vedere con la scarsa volontà o l’assenza di disciplina.
La fatica mentale costante, il senso di vuoto e il bisogno di isolarsi sono manifestazioni che, se riconosciute in tempo, permettono di intervenire prima che si trasformino in un ostacolo insormontabile. Non è raro che la persona cominci a evitare le lezioni, rimandare esami o rinunciare a relazioni sociali per la paura di non riuscire a gestire la pressione. In questo contesto, la cronicizzazione dei sintomi può compromettere sia il rendimento accademico sia l’autostima.
Un altro segnale importante è la disorganizzazione marcata: dimenticare scadenze fondamentali, non riuscire a pianificare lo studio, avere la scrivania invasa da materiale senza ordine. Questo aspetto, spesso liquidato come disattenzione, può invece essere un indicatore di condizioni come l’ADHD in età adulta, che nei contesti universitari è meno conosciuto e più difficile da diagnosticare.
Va ricordato che anche i sintomi fisici hanno un ruolo. Tachicardia, disturbi gastrointestinali, tensione muscolare e insonnia sono spesso correlati a stati d’ansia persistente e si ripercuotono sulla lucidità mentale. Se questi problemi diventano quotidiani, è importante non rimandare il confronto con un professionista.
La tendenza a minimizzare il disagio nasce dal timore di essere giudicati o di ricevere etichette stigmatizzanti. In realtà, riconoscere un disturbo è un atto di responsabilità verso se stessi e non implica automaticamente l’obbligo di assumere farmaci o di intraprendere un percorso di cura se non lo si desidera. La diagnosi è uno strumento che permette di conoscere le proprie difficoltà e di accedere a forme di supporto specifico, dagli esoneri a eventuali aiuti tecnologici.
Se ti accorgi che lo studio è diventato fonte di angoscia quotidiana, che la motivazione si è dissolta e che il corpo ti manda segnali di allarme, fermarti a riflettere può cambiare la prospettiva. Osservare e annotare i sintomi, anche in forma di diario, aiuta a capire se si tratta di un momento di stanchezza o di qualcosa di più strutturato. Questa consapevolezza è il primo passo per smettere di giudicarsi e cominciare a cercare aiuto con maggiore lucidità e fiducia.
Parlare con il medico o lo psicologo universitario
Dopo aver riconosciuto che i sintomi non si stanno risolvendo spontaneamente, il passaggio successivo consiste nel parlare apertamente con un professionista. Il primo riferimento può essere il medico di base, che conosce la tua storia clinica generale e può valutare se i disturbi hanno radici psicologiche, fisiche o una combinazione delle due. Portare con sé un elenco dei sintomi più frequenti, annotati con date e situazioni in cui si manifestano, facilita il colloquio e aiuta a evitare di dimenticare dettagli importanti.
Se sei iscritto a un ateneo, puoi accedere anche al servizio di supporto psicologico universitario, spesso gratuito o a costo ridotto. Gli psicologi interni alle università conoscono bene l’impatto che ansia, depressione o disturbi dell’attenzione possono avere sul rendimento e sono formati per orientare verso un percorso diagnostico mirato. Confrontarsi con loro permette di affrontare le prime paure e di ricevere indicazioni chiare sulle possibilità di presa in carico specialistica.
Il colloquio con il professionista è uno spazio protetto dove esprimere senza giudizio ciò che stai vivendo. Parlare della paura di fallire, del senso di vergogna o della sensazione di essere diversi dagli altri aiuta a ridurre il peso emotivo e a normalizzare l’esperienza. Molti studenti scoprono in questa fase di non essere affatto soli e di condividere sintomi comuni a tanti coetanei.
Una volta raccolte le informazioni, il medico di base o lo psicologo può rilasciare un’impegnativa per la visita psichiatrica o neuropsichiatrica, necessaria per approfondire la situazione. Questo documento consente di prenotare un appuntamento presso un servizio pubblico, un consultorio specialistico o un centro accreditato. In alternativa, chi desidera ridurre i tempi d’attesa può rivolgersi a un professionista privato, a proprie spese, purché sia un medico abilitato alla diagnosi e alla certificazione dei disturbi mentali e neuropsichiatrici.
Affidarsi a figure sanitarie qualificate è importante anche per escludere altre cause organiche che possono mimare i sintomi psicologici, come squilibri ormonali o carenze nutrizionali. In questo modo si evitano diagnosi frettolose e si riceve un piano di valutazione completo.
Prendere contatto con un medico o uno psicologo non obbliga ad alcun trattamento. È semplicemente un passo per acquisire consapevolezza e raccogliere informazioni utili a decidere come proseguire. Essere ascoltati con rispetto e ricevere rassicurazioni competenti può alleggerire subito la sensazione di smarrimento che spesso accompagna chi sta vivendo un periodo di fragilità emotiva.
La valutazione clinica e i test standardizzati
Dopo aver ottenuto l’impegnativa o deciso di affidarsi a uno specialista privato, si passa alla valutazione clinica vera e propria. Questo momento può generare un certo timore, ma è in realtà un processo strutturato che serve a comprendere in modo oggettivo la natura e la gravità dei sintomi.
Il primo passo consiste nel colloquio clinico approfondito. Lo specialista raccoglie la tua storia personale, le esperienze familiari di disagio psicologico, eventuali diagnosi precedenti e l’andamento dei sintomi nel tempo. Raccontare come l’ansia, la depressione o le difficoltà di attenzione influenzano la vita universitaria permette di costruire un quadro chiaro e dettagliato.
Alla raccolta anamnestica si affiancano i test psicodiagnostici standardizzati. Tra i più utilizzati c’è il DASS-21, che misura i livelli di ansia, depressione e stress attraverso un questionario autovalutativo. Se emergono difficoltà marcate di concentrazione, impulsività o disorganizzazione, è frequente che lo specialista proponga anche la somministrazione del Conners Adult ADHD Rating Scale, uno strumento specifico per individuare il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività in età adulta. Questi test non sostituiscono la valutazione clinica ma forniscono un supporto oggettivo che aumenta l’affidabilità della diagnosi.
In alcuni casi, per escludere cause organiche che potrebbero spiegare sintomi simili, vengono prescritti esami di laboratorio. Ad esempio, squilibri della tiroide, carenze vitaminiche o infezioni croniche possono manifestarsi con stanchezza, agitazione e calo della motivazione. Avere un approccio che integra la dimensione psicologica e quella biologica garantisce una maggiore precisione diagnostica.
Il percorso di valutazione può richiedere più incontri, specialmente quando si sospettano condizioni complesse o comorbidità tra disturbi differenti. Ogni passaggio viene documentato con attenzione, così che al termine sia possibile redigere una relazione completa e trasparente.
È importante sapere che la valutazione non ha lo scopo di etichettare la persona o ridurla alla definizione di una patologia. L’obiettivo è comprendere con esattezza quali siano le difficoltà reali e su quali aspetti concentrare il supporto. In molti casi, ricevere una spiegazione chiara delle proprie esperienze porta un sollievo immediato, perché finalmente i sintomi trovano un significato condiviso e smettono di sembrare un problema irrisolvibile.
Il momento della valutazione clinica è anche un’opportunità per esplorare eventuali opzioni di trattamento, dal supporto psicoterapeutico a interventi farmacologici, se necessari. Ogni proposta viene discussa con il paziente in modo consapevole e rispettoso, lasciando piena libertà di scelta. Una volta concluso il percorso, il professionista potrà redigere la certificazione ufficiale che servirà per richiedere i riconoscimenti e gli accomodamenti previsti dalla normativa vigente.
Ottenere la certificazione e chiedere accomodamenti
Se la valutazione clinica conferma che i sintomi rispettano i criteri diagnostici internazionali, lo specialista redige una relazione ufficiale che riporta la diagnosi con il relativo codice ICD-11, lo standard utilizzato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo documento è essenziale per avviare la procedura di riconoscimento della condizione di disabilità o disturbo specifico, che dà diritto a misure di supporto formale.
La certificazione viene consegnata in forma scritta e contiene una descrizione dettagliata delle difficoltà riscontrate, il loro impatto sul funzionamento quotidiano e le raccomandazioni per eventuali accomodamenti ragionevoli. È importante conservarne copia e chiedere chiarimenti su ogni parte del referto, così da comprenderne a pieno il contenuto e le implicazioni.
Con questa relazione è possibile presentare domanda alla Commissione sanità della ASL di residenza o, in molti atenei, direttamente allo sportello disabilità e DSA. La procedura può variare leggermente in base alla regione o all’università, ma in genere prevede la compilazione di un modulo di richiesta, l’allegato della certificazione medica e la consegna di eventuale ulteriore documentazione (ad esempio certificati pregressi o relazioni di altri specialisti).
Se la domanda viene accolta, l’ente competente rilascia la documentazione che attesta ufficialmente il diritto a ricevere misure di supporto personalizzate. Si tratta di un passaggio fondamentale perché solo con questo riconoscimento gli studenti possono accedere agli strumenti previsti dalle Linee Guida CNUDD 2024. Tali linee guida stabiliscono criteri omogenei per garantire pari opportunità a chi vive con una condizione certificata, indipendentemente dall’ateneo di appartenenza.
Ottenere la certificazione non implica automaticamente l’obbligo di usufruire degli accomodamenti. Alcuni studenti scelgono di richiederli subito, altri preferiscono farlo più avanti, quando si trovano in difficoltà con esami particolarmente complessi. La decisione è sempre individuale e revocabile in qualsiasi momento.
La consapevolezza di poter contare su un documento valido ai fini di legge aiuta a ridurre la pressione psicologica e a sentire di avere una tutela concreta. Sapere di poter richiedere estensioni di tempo alle prove, esoneri parziali dal programma, supporti tecnologici o modalità di esame personalizzate restituisce un senso di controllo sulla propria carriera accademica.
Se l’iter di certificazione appare complicato, è utile farsi affiancare da un referente dell’università o da un’associazione di tutela dei diritti degli studenti con disabilità. Avere un supporto in questa fase permette di chiarire eventuali dubbi e di evitare errori formali che potrebbero rallentare la pratica.
Attivare un piano di supporto personalizzato
Con la certificazione ufficiale riconosciuta dall’università o dalla ASL, diventa possibile attivare un piano di supporto individualizzato che risponda alle reali esigenze dello studente. Ogni ateneo dispone di uno sportello disabilità e DSA, dove un referente specializzato aiuta a definire le misure più adatte in base al tipo di disturbo, alla carriera universitaria e al livello di compromissione funzionale.
Tra le opzioni più richieste ci sono le estensioni di tempo durante gli esami, un sostegno prezioso per chi vive con difficoltà di concentrazione o rallentamento dei processi cognitivi. Questo accorgimento permette di svolgere le prove senza la pressione eccessiva che spesso aggrava l’ansia e compromette la performance. In alcuni casi è possibile richiedere esoneri parziali da alcune parti del programma, laddove siano considerate incompatibili con la condizione certificata, purché non pregiudichino gli obiettivi formativi del corso di studi.
Un altro strumento importante è il tutorato individuale, che può assumere diverse forme: incontri regolari per organizzare lo studio, supporto nella gestione delle scadenze, aiuto nell’uso di software compensativi. Molti atenei hanno attivato progetti di affiancamento digitale per studenti con ADHD o disturbi d’ansia, prevedendo l’accesso a piattaforme che migliorano la pianificazione e riducono il rischio di dispersione.
L’università può mettere a disposizione anche sussidi tecnologici, come registratori digitali per le lezioni, software di sintesi vocale o strumenti per la creazione di mappe concettuali. Questi strumenti aiutano a ridurre lo sforzo cognitivo e a mantenere la motivazione, soprattutto nei periodi di maggiore vulnerabilità emotiva.
Se si preferisce un percorso privato, centri certificati come gam-medical.com offrono un approccio multidisciplinare che comprende la valutazione con psichiatra, psicologo e logopedista. Questo modello consente di completare l’iter diagnostico in tempi contenuti, spesso in due o tre incontri, e ricevere un referto conforme ai requisiti di legge per la presentazione delle pratiche universitarie. La possibilità di avere un team dedicato aumenta la qualità della presa in carico e riduce il rischio di frammentare le informazioni tra più specialisti.
Richiedere un piano di supporto non significa rinunciare alla propria autonomia. Al contrario, è un modo per strutturare un percorso di studio sostenibile e rispettoso delle proprie caratteristiche individuali. Sapere di avere un ventaglio di strumenti a disposizione offre sicurezza e consente di affrontare il percorso accademico con maggiore fiducia.
Chi ha già ottenuto un piano può in ogni momento aggiornarlo se la situazione clinica evolve o se cambiano le esigenze formative. È sufficiente presentare una nuova documentazione medica e concordare con il referente universitario le modifiche necessarie. Questa flessibilità garantisce un sostegno che si adatta nel tempo e accompagna lo studente fino al conseguimento del titolo.
Riconoscere che vivere un periodo di ansia, depressione o difficoltà di attenzione non è un segno di debolezza ma un’esperienza umana che può riguardare chiunque è un passaggio decisivo per smettere di sentirsi soli. Ogni studente ha il diritto di ricevere ascolto, comprensione e un supporto adeguato per esprimere il proprio potenziale, senza essere ostacolato da pregiudizi o procedure complicate.
Chiedere aiuto non è un privilegio riservato a pochi, ma un diritto tutelato dalla legge e riconosciuto da tutte le istituzioni universitarie. Avere una diagnosi chiara e poter contare su un piano di sostegno personalizzato permette di trasformare le difficoltà in punti di forza, ritrovando fiducia nelle proprie capacità.
Nessun percorso accademico deve essere affrontato in solitudine. Parlare dei propri vissuti con professionisti qualificati, informarsi sui servizi disponibili e pretendere che vengano rispettati i propri diritti è un modo per prendersi cura di sé con responsabilità. La salute mentale è un aspetto fondamentale della vita universitaria e non può essere messa in secondo piano.
Scegliere di farsi aiutare è un atto di coraggio e autodeterminazione che merita rispetto e sostegno. Ogni passo compiuto verso la consapevolezza e la tutela del proprio benessere è un investimento che durerà ben oltre il periodo degli studi.
Riproduzione riservata © Copyright La Milano